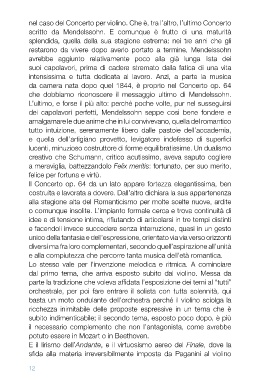Page 14 - Programma di sala - 12 marzo 2021
P. 14
nel caso del Concerto per violino. Che è, tra l’altro, l’ultimo Concerto
scritto da Mendelssohn. E comunque è frutto di una maturità
splendida, quella della sua stagione estrema: nei tre anni che gli
restarono da vivere dopo averlo portato a termine, Mendelssohn
avrebbe aggiunto relativamente poco alla già lunga lista dei
suoi capolavori, prima di cadere stremato dalla fatica di una vita
intensissima e tutta dedicata al lavoro. Anzi, a parte la musica
da camera nata dopo quel 1844, è proprio nel Concerto op. 64
che dobbiamo riconoscere il messaggio ultimo di Mendelssohn.
L’ultimo, e forse il più alto: perché poche volte, pur nel susseguirsi
dei capolavori perfetti, Mendelssohn seppe così bene fondere e
amalgamare le due anime che in lui convivevano, quella del romantico
tutto intuizione, serenamente libero dalle pastoie dell’accademia,
e quella dell’artigiano provetto, levigatore indefesso di superfici
lucenti, minuzioso costruttore di forme equilibratissime. Un dualismo
creativo che Schumann, critico acutissimo, aveva saputo cogliere
a meraviglia, battezzandolo Felix meritis: fortunato, per suo merito,
felice per fortuna e virtù.
Il Concerto op. 64 da un lato appare fortezza elegantissima, ben
costruita e lavorata a dovere. Dall’altro dichiara la sua appartenenza
alla stagione alta del Romanticismo per molte scelte nuove, ardite
o comunque insolite. L’impianto formale cerca e trova continuità di
idee e di tensione intima, rifiutando di articolarsi in tre tempi distinti
e facendoli invece succedere senza interruzione, quasi in un gesto
unico della fantasia e dell’espressione, orientato via via verso orizzonti
diversi ma fra loro complementari, secondo quell’aspirazione all’unità
e alla compiutezza che percorre tanta musica dell’età romantica.
Lo stesso vale per l’invenzione melodica e ritmica. A cominciare
dal primo tema, che arriva esposto subito dal violino. Messa da
parte la tradizione che voleva affidata l’esposizione dei temi al “tutti”
orchestrale, per poi fare entrare il solista con tutta solennità, qui
basta un moto ondulante dell’orchestra perché il violino sciolga la
ricchezza inimitabile delle proposte espressive in un tema che è
subito indimenticabile; il secondo tema, esposto poco dopo, è più
il necessario complemento che non l’antagonista, come avrebbe
potuto essere in Mozart o in Beethoven.
E il lirismo dell’Andante, e il virtuosismo aereo del Finale, dove la
sfida alla materia irreversibilmente imposta da Paganini al violino
12